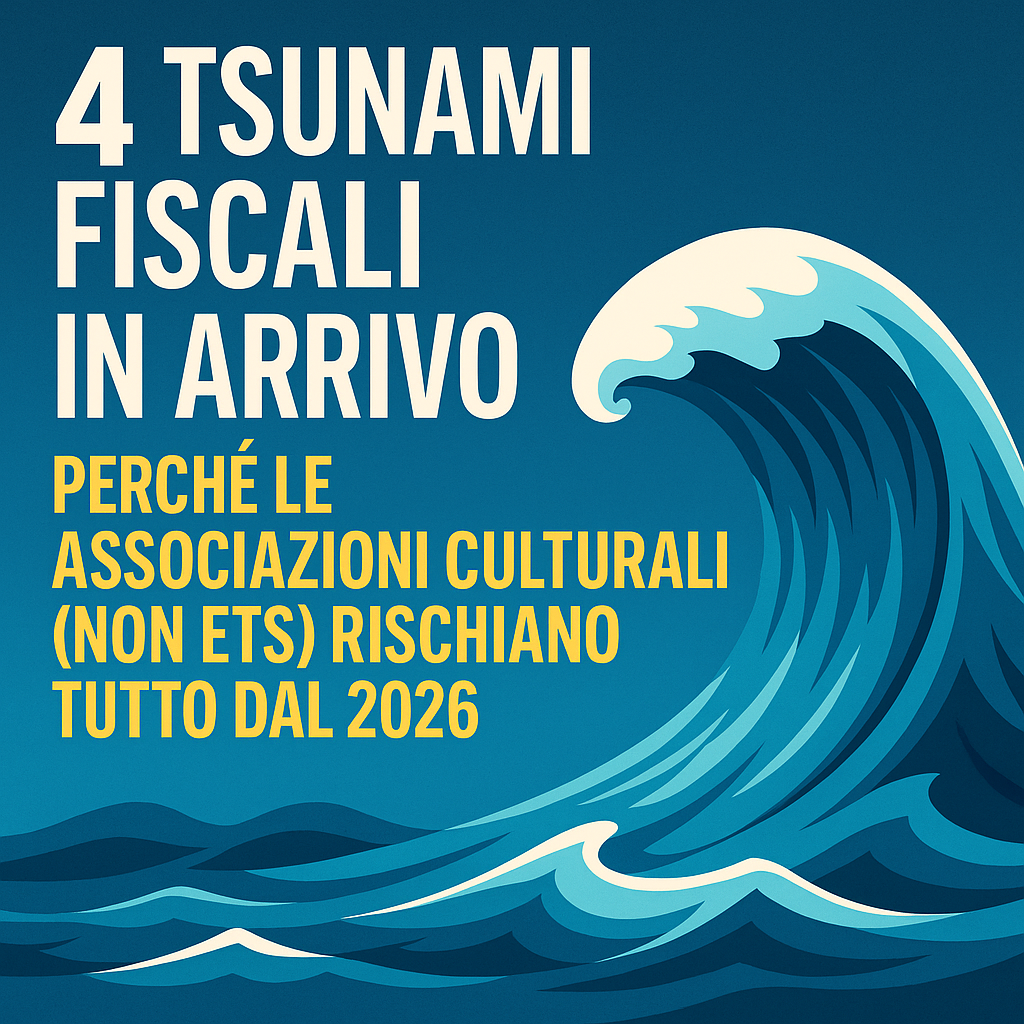4 Tsunami Fiscali in Arrivo: Perché le Associazioni Culturali (non ETS) Rischiano Tutto dal 2026
Una Scadenza Silenziosa che Cambierà Tutto
Chi gestisce un’associazione culturale lo fa spinto da passione, dedizione e dal desiderio di creare valore per la propria comunità. In mezzo a mille impegni organizzativi e burocratici, è facile perdere di vista le scadenze normative più lontane. Eppure, una data si avvicina silenziosamente e rischia di stravolgere completamente il panorama fiscale: il 1° gennaio 2026.
Per tutte le associazioni culturali che hanno scelto di non entrare nel Terzo Settore (non ETS), questa data segna un punto di non ritorno. Le agevolazioni fiscali su cui per decenni si è basata la loro sostenibilità economica verranno meno, sostituite da un regime molto più oneroso e complesso. Questo non è un semplice aggiornamento normativo, ma un vero e proprio cambio di paradigma.
È un campanello d’allarme che non può più essere ignorato. Ecco i quattro cambiamenti più impattanti che ogni associazione culturale deve conoscere per non farsi trovare impreparata.
Takeaway 1: Addio alla “Decommercializzazione”: I Servizi ai Soci Diventano Tassati
Il cambiamento più radicale riguarda l’abrogazione della principale agevolazione fiscale prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Fino ad oggi, questa norma permetteva di considerare “non commerciali” (e quindi non tassate) le entrate derivanti da servizi specifici forniti ai propri soci a fronte del pagamento di un corrispettivo. Questa agevolazione non riguardava solo le associazioni culturali, ma anche le associazioni assistenziali, di formazione extra-scolastica della persona e di promozione sociale.
Dal 1° gennaio 2026, questa fondamentale agevolazione cesserà di esistere.
La conseguenza diretta è che tutti i ricavi provenienti da queste attività (corsi, workshop, accessi a spazi, etc.) saranno considerati a tutti gli effetti proventi commerciali. Pertanto, su queste entrate l’associazione dovrà pagare l’IRES (l’imposta sul reddito delle società). Si tratta di un colpo durissimo al cuore finanziario di moltissime realtà associative, che basano la propria sostenibilità proprio su queste interazioni con i soci.
L’impatto di questa e della prossima modifica è stato definito devastante:
Si tratta, quelle sopra descritte, di 2 modifiche che andranno a impattare in modo devastante sulla portata delle agevolazioni fino a ora concesse al comparto degli enti non commerciali, soprattutto quelli di tipo associativo.
Takeaway 2: Il Regime Forfettario 398 Scompare: Più Complessità e Tasse sui Proventi Commerciali
In parallelo alla fine della decommercializzazione, viene abrogato anche il regime forfettario della Legge n. 398/1991. Questo regime è stato per anni uno strumento preziosissimo non solo per le associazioni culturali, ma anche per associazioni senza fine di lucro, pro loco, associazioni bandistiche e cori, associazioni amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare. Offriva un metodo estremamente semplificato per la gestione dell’IVA e delle imposte dirette sui proventi commerciali.
L’effetto combinato di questi due cambiamenti è un “doppio smacco” micidiale:
1. Aumentano i ricavi commerciali: Molte entrate che prima erano considerate istituzionali (servizi ai soci) diventano commerciali (Takeaway 1).
2. Scompare il regime più vantaggioso: Viene eliminato il modo più semplice ed economico per gestire fiscalmente proprio quei ricavi commerciali (Takeaway 2).
Le associazioni saranno quindi costrette ad abbandonare la semplicità del regime 398 per adottare i regimi contabili ordinari, molto più complessi, costosi e che probabilmente porteranno a un carico fiscale maggiore.
Takeaway 3: Il Rischio Esistenziale: Perdere lo Status di Ente Non Commerciale
Questo è forse il rischio più grande e sottovalutato. L’art. 149 del TUIR stabilisce i criteri secondo cui un ente può perdere la qualifica di “ente non commerciale”. La norma individua specifici “fatti indice di commercialità” per verificare se, al di là dello statuto, l’attività commerciale sia diventata prevalente rispetto a quella istituzionale.
Il collegamento con i punti precedenti è diretto e pericoloso. Poiché i corrispettivi per i servizi ai soci diventeranno a tutti gli effetti ricavi commerciali, l’impatto sul principale indicatore di commercialità — la prevalenza dei ricavi da attività commerciali rispetto alle attività istituzionali — sarà enorme. Per molte associazioni, l’attività commerciale rischierà di diventare, ai fini fiscali, l’attività principale dell’ente.
La conseguenza non è solo un aumento delle tasse, ma la riqualificazione dell’intera associazione da ente non commerciale a ente commerciale. Questo comporta la perdita di tutte le agevolazioni residue e un completo stravolgimento degli obblighi contabili, fiscali e gestionali. Come sottolinea la fonte, si tratta di un rischio “tutt’altro che remoto”.
Takeaway 4: Le Agevolazioni Rimaste? Poche e Difficili da Applicare
A fronte di un tale smantellamento, cosa rimane a disposizione delle associazioni culturali non ETS? Purtroppo, ben poco, e con applicabilità molto limitata. Le principali agevolazioni superstiti sono:
• Raccolte pubbliche occasionali di fondi: Permette di non tassare i fondi raccolti, ma solo a condizioni molto rigide. Devono essere eventi pubblici, occasionali e avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
• Contributi pubblici per attività in convenzione: La detassazione si applica ai contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche per svolgere attività convenzionate, ma solo a due condizioni: l’attività deve avere finalità sociali ed essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente.
• Il nuovo regime forfettario (art. 145 TUIR): Sebbene esista, questo regime è palesemente “inferiore” in termini di benefici rispetto al 398. Ad esempio, non prevede un parallelo regime semplificato ai fini IVA, rendendolo meno vantaggioso.
La stessa norma generale sulla non commercialità dei servizi (art. 143 TUIR) è considerata una “norma in bianco” di difficilissima applicazione pratica. Per poter detassare un servizio, infatti, devono essere soddisfatte congiuntamente quattro rigide condizioni:
1. Il servizio non deve rientrare tra le attività commerciali elencate nell’art. 2195 del Codice Civile.
2. Il servizio deve essere coerente con le finalità istituzionali dell’ente.
3. Il servizio deve essere svolto senza una specifica organizzazione d’impresa.
4. I corrispettivi ricevuti non devono superare i costi diretti sostenuti per erogare il servizio.
È evidente come queste opzioni residue, essendo di nicchia e soggette a condizioni stringenti, non compensino in alcun modo la perdita dei benefici ampi e quasi automatici garantiti dall’art. 148 del TUIR e dalla Legge 398.
Conclusione: Una Scelta Non Più Rimandabile
Il quadro che emerge è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: dal 1° gennaio 2026, l’ambiente fiscale per le associazioni culturali al di fuori del Terzo Settore diventerà sostanzialmente più ostile. I pilastri fiscali su cui si è retto per trent’anni il mondo associativo verranno demoliti, senza essere sostituiti da normative di analogo tenore.
La migrazione di molte attività verso l’area della commercialità non solo aumenterà il carico fiscale e la complessità gestionale, ma espone le associazioni a un rischio esistenziale di riqualificazione come ente commerciale.
Di fronte a questo scenario, la vera domanda non è se cambiare, ma come prepararsi. La vostra associazione è pronta a navigare questa nuova realtà, o è arrivato il momento di valutare seriamente l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?